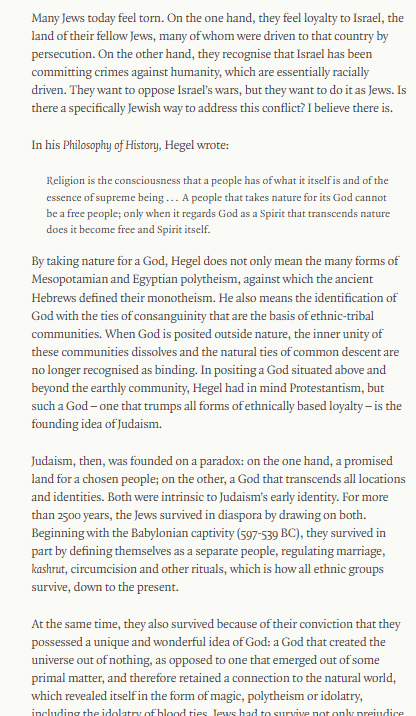di Francesco Petracca
Accade spesso che i dibattiti su questioni politiche siano approcciati in maniera sconsiderata e pregiudiziale, assumendo come granitiche posizioni in realtà sfaccettate e identificando connessioni logiche non pienamente trasparenti. Si tratta certamente di un difetto della democrazia in cui è radicata quella reazione di rigetto espressa nel luogo comune “ma allora tutti possono dire tutto!”.
Noi non crediamo (ovviamente) che sia necessaria una restrizione della volontà di parola né che il dibattito pubblico abbia bisogno di alcuna forma di patente o autorizzazione governativa. Nondimeno, riteniamo che affinché la discussione pubblica sia effettivamente capace di essere un vettore di libertà politica coloro è necessario che coloro che vi partecipano abbiano una panoramica quanto più ampia possibile delle posizioni, dei cavilli e degli sfumature in gioco.
L’articolo che qui vi offriamo è composto precisamente a partire da questo spirito. Oggi, desideriamo parlarvi di Ely Zaretsky, professore di storia alla New School for Social Research. Zaretsky è ebreo, americano e studioso delle questioni politiche e culturali dell’ebraismo (soprattutto in riferimento a Freud). A seguito del rinnovato infiammarsi della questione palestinese a partire dall’ottobre 2023, Zaretsky ha preso posizione in maniera aperta sui molti difficili dibattiti circa il conflitto, andando ai ferri corti con la fatidica sul rapporto fra antisionismo e antisemitismo.
Questo nostro articolo raccoglie le posizioni di Zaretsky esposte sulla London Review of Books in due pezzi, Israel and the Crisis of Judaism (febbraio 2024) e The Post-Zionist Jew (ottobre 2024) nella speranza che le argomentazioni di questo illustre autore possano dare da pensare ai nostri letttori (food for thoughts!).
In una lettera dalla Libia del 1963, Calvino scriveva: «La sensazione che dà il deserto è quella della sua infinita unità e nello stesso tempo non si dimentica mai che è formato da minutissimi granellini: è chiaro che il monoteismo è nato da persone che passavano giorni e mesi camminando nel deserto».
La novità del monoteismo fu appunto, con le parole di Zaretsky, «un’idea unica e meravigliosa di Dio: un Dio che creò l’universo dal nulla, opposto rispetto alle divinità che emergevano da qualche materia primordiale, perciò relegate a una connessione con il mondo naturale, rivelando sé stesse in forma di magia, politeismo o idolatria, inclusa l’idolatria dei legami di sangue»¹.
Se le religioni del mondo antico cercavano espressioni divine in singoli elementi del proprio ambiente (il fuoco, l’acqua, il fulmine, il sole), la religione del popolo ebraico fu unica e pioniera nel pensare la divinità come un tutto collocato fuori dalla natura, un cerchio che contenesse nel suo perimetro ogni entità, elemento, individuo, ecc.
È precisamente questo aspetto che Eli Zaretsky cerca di sottolineare: la profonda matrice universalista dell’ebraismo, la quale concepisce ogni cosa come creata divinamente da un singolo Dio. Tuttavia, l’autore ci tiene a ricordare che dall’altro lato della medaglia, rovesciando la faccia dell’universalismo c’è un controlaltare nell’ebraismo: la concezione del popolo ebraico come soggetto prescelto e quindi protagonista del disegno divino. Di facile intuizione è il paradosso: come può il pensiero universalista conciliarsi con la prospettiva etnica e individuale di un singolo popolo, apparentemente più importante degli altri? come si può pensare all’infinita unità del deserto e intanto ritenere che uno dei suoi granelli sia prescelto? se Dio si colloca al di sopra di ogni elemento naturale, perché dovrebbe prediligere un popolo sugli altri, prendendo parte al mondo della natura? Nel momento in cui ad essere superati sono – con le parole di Zaretsky – “i legami di sangue”, cosa differenzia lo scopritore di questa verità da chi non vi ha avuto accesso?
Chiaramente questa incompatibilità di visioni può essere spiegata attraverso una prospettiva storica (lasciando da parte per un attimo la teologia): è infatti tendenza comune all’interno delle società connotare in senso identitario elementi culturali della propria quotidianità o della propria storia: dalla lingua all’arte, dalle pratiche gastronomiche all’abbigliamento, passando anche per le credenze religiose, tutti questi elementi non sono solamente funzionali per la sopravvivenza, ma diventano marcatori di appartenenza a una comunità.
La concezione universalista del mondo era, a suo tempo, una specificità del popolo ebraico. Ed è perciò facile immaginare che un fatto così inedito separasse tale popolo da tutti gli altri, a tal punto da far penetrare questa distinzione all’interno della dottrina stessa. La solitudine e la separatezza del popolo ebraico non sono certo una novità: «a partire dalla cattività babilonese (597-539 a.C.), [gli ebrei] sono sopravvissuti in parte definendosi un popolo separato, regolarizzando il matrimonio, attraverso la kasherut, la circoncisione e altri rituali, come sopravvivono tutti i gruppi etnici, fino al presente»².
La storia del popolo israelita è stata, infatti, per la sua maggior parte, un percorso cosmopolita e apolide. Come fa notare Erich Fromm, riprendendo così la citazione iniziale, la vita nel deserto ha influenzato le abitudini degli ebrei: «il deserto non è una patria: non ha città, non ha ricchezze, è il luogo in cui vivono i nomadi che possiedono ciò di cui hanno bisogno, e ciò di cui hanno bisogno sono non già possessi, bensì le cose necessarie all’esistenza. […] Alcuni dei fondamentali simboli delle festività ebraiche traggono origine proprio dal rapporto con il deserto: il pane azimo è proprio di coloro che hanno fretta di andarsene, il pane dei pellegrini; il suka ( “tabernacolo” ) è la casa del nomade: l’equivalente della tenda, facile da erigere e altrettanto facile da smontare. Secondo la definizione del Talmud, esso è “la dimora transitoria” in cui vivere, contrapposta alla “dimora fissa” che si possiede». Questo insieme di tradizioni e interpretazioni della propria esistenza entra in crisi, secondo Zaretsky, con l’approdo alla modernità, in particolare nella forma dell’Illuminismo e delle sue rivoluzioni democratiche.
Grazie ad esse
«gli ebrei vennero rilasciati dai loro ghetti e divennero cittadini. Ciò portò a un conflitto tra ebrei anziani, i quali tendevano a mantenere la tradizione, e i più giovani, che invece tendevano ad abbracciare la scienza moderna, il pensiero liberale e socialista. […] Se il mondo moderno si fosse mosso verso traguardi universalisti di eguaglianza e giustizia³ […] il sionismo non sarebbe mai esistito. Accadde infatti che il matrimonio tra ebrei e universalismo li rese maggiormente i bersagli dell’odio antisemita. Il sionismo nacque come risposta a quell’odio, ai pogrom degli anni Ottanta dell’Ottocento, al caso Dreyfus del decennio seguente»⁴.
L’odio contro l’universalismo ebraico sopravviverà per tutta la prima metà del Novecento; non bisogna dimenticare infatti che Mussolini introdusse forti elementi antiebraici nelle leggi razziali non solo per influenza tedesca, ma soprattutto perché riteneva che l’ebraismo internazionale fosse parte attiva dell’antifascismo.
Pur con le contingenze storiche che modificano e confondono le linee, ci troviamo alla fine con le stesse due tendenze: da una parte l’universalismo e dall’altra il particolarismo di un singolo popolo. Interpretando il sionismo come una degenerazione – certamente causata da eventi aggressivi e traumatici – della seconda tendenza, Zaretsky sostiene che si possa invece ripensare l’ebraismo riportandolo verso la prima, saremmo dunque davanti a una figura di post-Zionist Jew, ebreo post-sionista.
«C’era un’alternativa reale al sionismo: il socialismo, il quale conquistò la fedeltà di tanti ebrei quanti ne conquistò il sionismo»⁵.
Solo rifiutando il sionismo e le sue dottrine si possono recuperare i valori positivi e strettamente progressisti della religione ebraica. In un sistema millenario di continui sorpassi e spostamenti in avanti, che ha portato dall’ebraismo al cristianesimo, dal cattolicesimo al protestantesimo e da quest’ultimo al clima culturale che ha prodotto l’Illuminismo, sembra oggi necessario riprendere il primo anello della catena, per tentare di riassorbire la sua capacità innovatrice e la sua radicalità originaria, sorpassando la dannosa declinazione sionista, perché «l’ebraismo può sopravvivere in una forma significativa solo se essa non è fondata sulla lealtà etnica. Deve essere, in una parola, non-, post- o anti-sionista»⁶.
Si tratta, in breve, di oppore contro il particolarismo di Israele non un altro particolarmismo o la gelida logica dei terrorismi bensì l’universalismo moderno costituito a partire dal contributo che migliaia (se non milioni) di persone, tra cui numerosissimi ebrei⁷. Pensando così il sionismo come un prodotto locale di una reazione traumatica alla modernità, ricercare il filo rosso dell’universalismo (ebraico) significa trovare una sorgente di motivi da cui attingere per esprimere una necessaria radicalità, che ancora oggi, come migliaia di anni fa, riesca a spostare in avanti i valori e gli ideali del nostro mondo. Altre prospettive ci sembrano, in tutta onestà, inconciliabili con i valori storici della sinistra.
1 qui
2 qui
3 qui
4 qui
5 qui
6 qui
7 qui