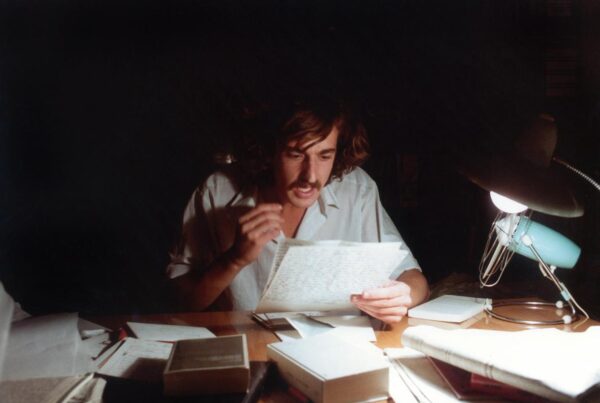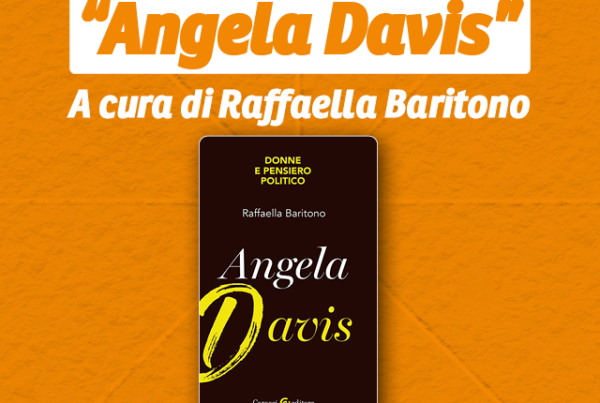di Francesco Petracca
Che la politica italiana sia in crisi non è una novità del terzo millennio o degli ultimi anni. Anzi, forse non c’è parola più efficace di questa, di “crisi”, che riesca a riassumere in appena cinque esili lettere la sostanza di una Repubblica che nei suoi 78 anni di storia ha generato una fittissima totalità di 68 governi. E sebbene lo stivale sia la comune (diremmo quasi: istituzionale) pareidolia prodotta sulla fisionomia del nostro Paese, sembrerebbe a tutti gli effetti che la deambulazione, l’equilibrio e il passo deciso non appartengano al nostro complesso ma meraviglioso sistema politico (tanto equilibrato da non stare in piedi, sosterrebbe qualcuno). Tra la gente si cattura diffusamente una tendenza al decadentismo, al recupero nostalgico degli antichi Titani un tempo calunniati con monetine, cori denigratori, accuse scalmanate o altre manifestazioni di aperto dissenso.
Il sistema politico appare lontano, separato dal quotidiano, inefficace nel soddisfare i bisogni reali. Gli occhi e le dita dei comuni mortali disegnano una parabola discendente: ci dicono che si sta calando a picco, che la qualità delle figure istituzionali è scadente, e questo disegno corrisponde, bene o male, alla sempre minor partecipazione, sia questa sociale o elettorale. L’elettorato si ritira, diserta la mansione e preferisce l’apatia, forse la peggior forma di indifferenza perché aggiunge ad essa quella punta amara di sincera delusione. Una volta l’aperto dissenso, oggi l’esclusione dall’esistente.
Nel calcolo di questa parabola tanto violenta quanto prevedibile, il fenomeno che porta il nome di Roberto Vannacci potrebbe sembrare solo uno dei tanti punti in perfetta soluzione di continuità coi suoi precedenti: pare, a prima vista, solo il gradino più basso e più recente del “trend negativo” (recitava a bordo piscina il comunista smemorato) ormai storicamente appurato.
Eppure Vannacci è un fenomeno diverso. Dal confronto televisivo con Calenda è emerso in tutta la sua forza, perciò tale evento ci permette di leggerlo e trovarne tutte le vulnerabilità e le particolarità.
Roberto Vannacci ascolta, non interrompe, sembra quasi non muoversi; la fronte resta sempre un poco corrugata, le sopracciglia sollevate; non ha il sorriso e la danza di Berlusconi, le mani invadenti e i cartelli pixelati di Salvini, l’escandescenza e l’idioma romanesco-popolare di Meloni. C’entra poco con gli altri o ex esponenti del centrodestra. Si direbbe che il suo personaggio in toto possiede una caratteristica che ultimamente porta indubbia fortuna e immediatamente ispira (almeno questo ci dicono i dati dell’editoria italiana, così come esperienze precedenti): non è un politico. Non ha la patina che maschera e disloca, quella sorta di retorica che sposta le domande e le schiva. Il linguaggio del Generale non nasconde, questo è certo, ma non si potrebbe nemmeno dire che mostri. Al contrario: Berlusconi mostrava, raccontava una verità agli italiani, indicava le tasse e diceva che erano soldi estorti all’“Italia che lavora”; in Vannacci questo non c’è, qui la verità non è una conseguenza deittica o dimostrativa, somiglia piuttosto a una scrollata di spalle leggera, scontata, naturale.
Vannacci scrive oscenità su omosessuali, femministe, persone non “caucasiche” etc, si esprime e si getta sul reale; poi però ritira tutto, fa un passo indietro, dice che è stato interpretato male, addirittura che per lui, magnanimo e strenuo sostenitore del multiculturalismo, le minoranze sono una ricchezza, che quando dice che gli omosessuali non sono normali non vi è connotazione negativa, ma semplice denotazione statistica. Facilmente si può dimostrare il contrario. Ci basterebbe anche la frase riportata testualmente e che ha destato più scalpore, ovvero, come dicevamo: “Cari omosessuali, normali non lo siete”. Davvero qui non c’è connotazione negativa? Ci sono dei semplici e immediati indizi
formali che ci aiutano. La frase si apre con un’apostrofe, “cari omosessuali,” la quale evidenzia il primo problema, ovvero l’immediatezza prorompente con cui si rivolge direttamente alle persone omosessuali, in una forma che si muove tra l’intimidatorio e il sarcastico. In queste due parole c’è già una forma di repressione. Poi c’è il costrutto marcato seguente, “normali non lo siete”, che presenta due problemi: se si vuole riportare uno studio statistico sulla sessualità degli italiani (e perché mai un Generale dovrebbe dilettarsi in tale progetto?) non si ricorrerà a formule così fortemente colloquiali e vicine al parlato. Forse la mappatura e la statistica non erano l’intento, ci viene da credere. Ma c’è anche un secondo problema, più contenutistico: ovvero la presenza dell’aggettivo e dunque della nozione di normalità, i quali rivelano apertamente che non si sta facendo un discorso analitico o euristico, cioè un discorso conoscitivo che vuole esplorare un’area, quanto piuttosto un discorso ermeneutico o interpretativo che intende trovare ed erigere un confine tra ciò che è normale e ciò che non lo è, tra ciò che la legge ammette e ciò che sanziona. Bastano poche parole per dimostrare che non è un discorso neutro e imparziale, che non è un discorso descrittivo; è invece un discorso violentemente prescrittivo.
Per giustificare la sua violenza e nasconderla, Vannacci cerca di tornare sempre sulla neutralità, questa è la sua cifra. Durante il confronto cita una pagina di Wikipedia e parla di una “definizione universalmente riconosciuta” di omosessualità (a quanto pare il suo tema preferito). Fa dunque affidamento a fonti esterne che appartengono a una pluralità di persone più affidabili e che rientrano nell’immaginario comune, cosicché lui possa uscirne intatto, sottile e nell’ombra. L’aneddoto (non così efficace) di Miss Zimbabwe ha le stesse finalità: spostare l’attenzione lontano da sé. Sembra giocare su continue allusioni, stimola lo spettatore povero di strumenti o banalmente intollerante parlando una sorta di sottocodice, e rischia di essere infinitamente più pericoloso degli altri prima di lui perché il suo personaggio non viene mai fuori del tutto. Non cessa di esprimersi ma rimane continuamente imprevedibile.
Con Salvini avveniva (ma forse non avviene più, visti i recenti risultati) qualcosa di diverso: il processo consisteva in una forte identificazione con lo spettatore/elettore: il politico è uno di noi, uno che parla come noi, che sta in mezzo a noi nelle piazze, che fa le cose che facciamo noi e si indigna per le cose che ci fanno indignare e quando finalmente salirà lì, nei palazzi del potere, avremo qualcuno dei nostri. L’elezione diventa un meccanismo di elevazione. Questo processo però si perde nel suo compimento, quando il politico è effettivamente eletto. Vannacci invece si posiziona o si trova a metà: non è un civis né un politico. Lo spettatore non si identifica nel Generale, ma vede un’altra forma di sé più edulcorata, più formalmente posata, con un lessico oggettivamente più ricco e impiegato con perizia rispetto a quello di Salvini o Meloni o dello spettatore stesso.
Roberto Vannacci, nelle sue espressioni, si ferma sempre un attimo prima. Non compie quel passo decisivo e definitivo, omette le conclusioni di cui i suoi enunciati sarebbero le naturali premesse. Lascia che sia lo spettatore a completare le frasi per lui, a trarne le conseguenze. Sembrerebbe insomma che non si tratti (come nei casi precedenti) di un’identificazione. Lo spettatore non vede sé stesso nell’immagine del Generale, ma, attraverso quest’ultima, giustifica sé stesso. I suoi discorsi servono come ponte per raggiungerne degli altri, funzionano da tramite, non hanno la propria forza in sé stessi. Berlusconi ha forgiato il suo elettorato, lo ha allevato, sono quasi cresciuti assieme, si potrebbe che dire che lo abbia creato lui. Qui invece l’identità dei destinatari non è prodotta o amplificata, ma semplicemente confermata.
Non si tratta più di un innalzamento plebiscitario, quanto piuttosto di una apparizione messianica o epifanica; Vannacci arriva da un luogo altro che n0n appartiene al popolo e gli parla da un punto più alto che riempie l’oratore di venerazione, con aspetti di idolatria ecclesiastica. In questo, è assolutamente berlusconiano: anche B. arrivava da un altro luogo, conosciuto ma misterioso e quasi mitologico, ovvero il mondo dell’imprenditoria di successo. Eppure Berlusconi rimaneva, sotto il doppiopetto e più o meno lontano dalle telecamere, spaventosamente italiano, con le sue barzellette, gli scandali, i piaceri. Appariva, in fondo, un uomo qualunque, anche (e purtroppo) da Presidente del Consiglio. Vannacci, invece, si toglie l’umanità. Sta lì immobile, come una statua muta e precisa, lancia nel mondo un mucchio di parole senza mai rivendicare il significato ultimo e lascia tutto il processo inferenziale nelle mani dell’ascoltatore, gli consegna cioè un’arma senza dirgli come si mette la sicura, a cosa serva, quando e dove usarla.
Questo stimolo senza origine o forma, questo parlare e poi lasciar interpretare che ricorda la comunicazione delle divinità, forse proprio perché se ne cancella la sorgente e si lascia il destinatario in balìa della corrente, rischiano di sfociare in modalità e situazioni pericolose e forse senza precedenti, da cui dovremo essere pronti a difenderci.