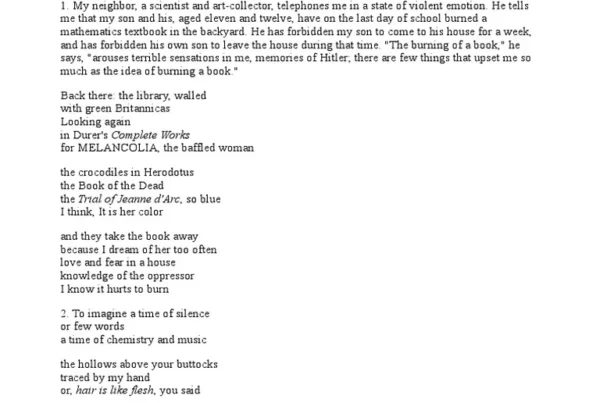PERCHÉ L’ARTICOLO “CALLY INCITA ALLA VIOLENZA? OK, BOOMER!” FA I CONTI SENZA L’OSTE(SSA)
diMarianna Campanardi, Chiara Stella Vannucci, Gaia Romani, Arianna Curti, Edoardo Cavaleri
«Si chiama Gioia ma beve e poi ingoia
Balla mezza nuda e dopo te la dà
Si chiama Gioia perché fa la troia
Sì, per la gioia di mamma e papà»
«Questa frate non sa cosa dice
Porca troia, quanto cazzo chiacchera?
L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa
C’ho rivestito la maschera»
Il rapper romano Junior Cally può partecipare a Sanremo oppure no?
Questa è la domanda che si è posta nell’ultima settimana l’opinione pubblica a causa di alcuni pezzi scritti dall’artista che contengono, secondo alcuni, un’incitazione alla violenza di genere, per altri uno spaccato della società in cui vive. Di sicuro, insieme ad altre, le parole che leggete sopra.
Il primo a sollevare la necessità di non permettere a Junior Cally di salire sul palco di Sanremo è stato Matteo Salvini, che lo ha fatto non per l’intento di spezzare una lancia a favore del rispetto per le donne ma perché la canzone in gara lo attacca chiaramente.
A quel punto, la discussione si è subito polarizzata tra chi inneggiava alla libertà di espressione del pensiero e contro la censura e chi invece voleva vietare la partecipazione del rapper al festival. Come succede spesso, ci siamo trovati alla polarizzazione del dibattito.
Partendo dal fermo presupposto che la musica è arte e come tale è libera e che nessuno vuole impedire ai cantanti di manifestare il proprio pensiero e la propria visione, l’occasione che sta andando sprecata è quella di aprire un dibattito serio sull’opportunità o meno di scegliere, in particolare quest’anno, un rapper che abbia scritto quei testi.
Il punto non è “svecchiare” il Festival invitando dei rapper e non è neanche capire le esigenze e il linguaggio di una generazione, la nostra (che non ha niente a che fare con lo scrivere cose come “troia”, “puttana” o “l’ho ammazzata”) ma è chiedersi: quali contenuti, quali messaggi, quali esigenze e quale voce di questa generazione vogliamo mettere in luce?
Sono tantissimi gli artisti che fanno rap che si sono posti fortemente contro la violenza di genere condannandola a viso aperto e in modo limpido. Perché non dare visibilità a loro?
Tanto più che questa polemica è sorta dopo la possibile esclusione della giornalista Rula Jebreal che, utilizzando il palco dell’Ariston, avrebbe proprio l’obiettivo di portare il tema del femminicidio all’attenzione dell’opinione pubblica. Molti hanno risposto dicendo che anche altri rapper che hanno utilizzato espressioni sessiste sono stati invitati in passato. Bene, e quindi? Perché non incominciare proprio adesso ad invitarne altri più attenti e sensibili al tema? Un’altra domanda che ci sembra spontaneo porci è questa: se Junior Cally si sente vittima di un equivoco e crede che i suoi testi siano stati fraintesi, perché non lo dice? Perché non si dichiara femminista e non chiede di poter esprimere il suo rispetto per le donne nel modo che preferisce, magari proprio al festival?
Ma veniamo alla questione linguistica. Il linguaggio ha per sua natura forza e potenza particolari non solo nel descrivere gli avvenimenti, ma nell’aiutare a sradicare tante parole da una visione prefissata nell’immaginario collettivo, rendendole libere ed inclusive. La lingua non si limita a descrivere e veicolare la realtà, la lingua è la realtà. Questo è il motivo per cui vi è stata un’evoluzione di tanti termini, questo è il senso di chiamare una donna “ministra” invece che “ministro”, per fare sì che il termine esprima al meglio l’appartenenza di quella persona rispettando la sua unicità, non omologandola ad una maggioranza opprimente e contribuendo così ad aggiungere un tassello alla parità.
Anche noi, come tutti, abbiamo pensato per diverso tempo che questi meccanismi fossero ininfluenti. Poi, studiando, approfondendo e soprattutto confrontandoci con le persone più coinvolte abbiamo compreso la rilevanza del linguaggio in quanto sostanza di significato. Ora, perché in un testo che non ha come obiettivo quello di istigare alla violenza di genere le donne sono definite “troie che ballano mezze nude, te la danno e poi ingoiano”?
Un concetto, per quanto provocatorio, può essere espresso in tanti modi senza ricorrere a termini come “troia” che, da dizionario, ha come primo significato “Femmina del maiale, termine usato per la scrofa quasi esclusivamente destinata alla riproduzione”. Questa parola definisce quindi la donna oggetto e animale che compie atti sessuali come una bestia, perché quella è la sua natura. La sessualità della donna ed il suo desiderio sono così ridotti al puro atto animale per l’utilità maschile. E trasmette l’idea che un comportamento sessualmente libero da parte di una donna sia a puro consumo di un uomo, che di lei (essa) potrà fare ciò che vuole, perché stiamo appunto parlando di un animale. All’inizio del testo le donne sono anche apostrofate come “quaranta fighe” (indicate solo tramite una loro parte del corpo). Come se non bastasse, più avanti c’è un bel “l’ho ammazzata”. Poesia pura.
Chi di noi è donna si sente personalmente svilita da questi termini se a pronunciarli è un uomo, perché vive sulla propria pelle ogni giorno qualcosa che dagli uomini può essere intuito (difficilmente capito fino in fondo) solo se c’è una grande volontà di mettersi “nei nostri panni”. Qualunque fosse l’intenzione dell’artista, né in lui né nei suoi sostenitori riconosciamo questa volontà, a differenza di quanto avviene con altri autori che scrivono con la consapevolezza del peso e del potere narrativo e semantico delle espressioni.
Le parole sono importanti. Lo sono nelle nostre vite private, lo sono a maggior ragione nelle vite pubbliche di chi non vuole essere equivocato per misogino. Non è questione di censure, ma di riflessione sul linguaggio.
Ed è con questa consapevolezza che, da qualche settimana, riflettiamo su cosa vorremmo vedere al Festival di Sanremo. In realtà non chiediamo molto, vorremmo solo godere di uno spettacolo che sia spazio di intrattenimento inclusivo per noi donne, per noi femministi, per noi minoranze e diversità di qualsiasi tipo. Insomma, che non sia il solo trastullo personale di chi come Amadeus evidentemente non sa riconoscere il proprio privilegio di categoria maggioritaria (uomo, eterosessuale, bianco, cisgender) e pensa di poter fare come se il mondo negli ultimi cinquant’anni non fosse cambiato. Già così, prima che scoprissimo i testi di Junior Cally, guardare Sanremo sarebbe stato per noi come infliggerci una punizione: ci fa male osservare l’harem di donne che stanno un passo indietro (e infatti non hanno aperto bocca durante la conferenza stampa) rispetto al conduttore uomo che le ha scelte perché «sono tutte molto belle». Ci fa male, ci fa sentire insultate, vilipese, escluse da qualcosa che è anche nostro.
Ed è per questo che siamo rimaste/i sbigottite/i leggendo le righe dell’articolo su Junior Cally pubblicato qualche giorno fa sul nostro blog e le difese aprioristiche di molte persone che sono entrate nella conversazione: prima dei generi musicali coinvolti, poi della “libertà di espressione” ad ogni costo e contro il “flagello” del politicamente corretto, poi delle stesse parole incriminate, perché in fondo “troia” si può usare per scherzare, perché tanto è sinonimo di “stronza” (no, non lo è), perché comunque più lo usi e più si stempera il significato (non è vero, e se qualcuno vi avesse chiamati così anche solo una volta forse capireste).
Una domanda sorge però spontanea: in quell’articolo le donne dove sono? Eh già, perché sono proprio loro che in prima persona hanno trovato il testo di Junior Cally offensivo. Ridurre la questione a un banale conflitto giovani-vecchi non rende giustizia in questa occasione a una categoria specifica: quelle che sono sia donne (e femministe) sia giovani, come quasi tutte noi autrici di queste righe. Quando si tratta di parità tra i sessi, spesso non ci si rende conto di come e quanto un linguaggio o un contenuto possano essere offensivi proprio perché si suole associare il maschilismo solo alla violenza fisica o alle discriminazioni evidenti sul lavoro. Ma in casi come questo basterebbe fare un passo indietro e domandarsi semplicemente: cosa ne pensano le donne? E il modo migliore per scoprirlo è chiederlo a loro. Troviamo alquanto singolare che, proprio dopo una rivolta delle donne, molte delle quali del nostro Partito, un uomo si permetta di stabilire cosa possa essere o meno offensivo per loro, per noi. Non perché un maschio non sia in grado di cogliere le sottili sfumature del sessismo, ma perché quella dei gender studies è una materia che va affrontata senza superficialità.
Potrei fare un esempio sfruttando un altro tipo di discriminazione più esplicito. La blackface è considerata molto offensiva dalla comunità nera; tuttavia, la prima volta che ho sentito un nero condannare la blackface ho pensato “che esagerato, ma cosa sarà mai”. Ma è proprio ascoltando e immedesimandosi nel soggetto interessato che si acquisisce la sensibilità giusta per affrontare il tema del razzismo nei media. Noi stessi non avremmo mai compreso cosa ci fosse di male, se una persona nera non ci avesse spiegato come questa pratica la faccia sentire. E ora non ci sogneremmo mai di dire “ma no, la blackface non è offensiva, state esagerando”.
Lo stesso avviene con il maschilismo: un uomo ha bisogno di venire in contatto con la sensibilità femminile per capire cosa la urti e per potersi immedesimare in essa. In parole semplici: se tu uomo che non trovi offensivo qualcosa ma leggi di migliaia di donne arrabbiate per quel “qualcosa” che le riguarda in prima persona, non ti fai due domande? Non credi che forse la tua interpretazione sia incompleta? Non senti il bisogno di chiedere “ragazze, perché questa cosa è offensiva per voi?”. Se chiedi ti risponderemo; se non lo farai, sarà soprattutto un peccato d’arroganza. Le chiavi quindi sono tre: il dialogo, la sensibilità e l’umiltà.
Anche se siamo nel 2020 è tutt’ora necessario ribadire il fatto che la lotta contro il sessismo e il maschilismo debba essere portata avanti anche e soprattutto dagli uomini. Il principio di base è semplice (in teoria): tutti e tutte dobbiamo avere gli stessi diritti e le stesse opportunità. Ma l’uguaglianza formale non basta. Ed è dovere e sentimento prima di tutto degli uomini indignarsi perché le donne vengono escluse anche con le parole dagli spazi, perché la nostra collega guadagna meno di noi, perché la nostra amica viene identificata tramite sue caratteristiche fisiche, perché nostra madre è stata costretta a rinunciare alla sua carriera per accudire noi figli.
La chiave è mettersi nei panni delle donne. Cercare di capire cosa significhi essere trattati come una minoranza (pur essendo, per altro, maggioranza). Cercare di capire come reagireste voi ad una società che vi giudica inferiori, stupidi, deboli. Chiunque di noi può trovarsi, in un momento della sua vita o per sempre, a far parte di un gruppo con meno diritti degli altri. Pensiamoci, perché succede e può sempre succedervi. Come vorreste essere trattati? Non portereste forse avanti le stesse rivendicazioni delle donne? Se abbiamo un colore della pelle diverso dal bianco, se abbiamo una disabilità fisica o mentale, se veniamo da un altro Paese, se siamo omosessuali, se siamo transgender, se solo non corrispondiamo ai “canoni” e ai ruoli in cui la società ci impone di rientrare come donne e come uomini. Ciascuno di noi può fermarsi a riflettere e capire cosa significhi essere emarginati, avere meno diritti degli altri, avere gli sguardi della gente addosso quando si cammina per strada. Se ci provate, sentirete allora nel profondo che la battaglia per i diritti e la dignità delle donne è la battaglia per i diritti e la dignità delle persone, cioè di tutti.
Perché tutte le persone meritano di essere ascoltate, incluse, rappresentate. Perché meritiamo rispetto.
Femminismo intersezionale: movimento culturale che prende forma dal femminismo storico (ovvero la lotta per la parità tra i generi) per includere nella battaglia per il riconoscimento e la rappresentanza tutte le minoranze discriminate, nella convinzione che tutti i soprusi e le discriminazioni possiedano una matrice comune. Insomma, lotta per tutt* noi.
«If I’m shining, everybody is gonna shine»
[Lizzo, Juice]